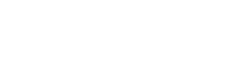Tribunale di Milano Sez. I Sent. 05/02/2020.
Ci siamo abituati in questo periodo di Quarantena forzata a sentire bollettini di morte.
Ogni giorno si contano i morti da Covid-19.
A chi viene travolto da questo tzunami non resta che pregare e affidarsi a quello che viene detto loro dagli esperti.
Ma la cronaca ci ha anche abituato a sentire purtroppo notizie che riguardano errori medici, talvolta anche grossolani dovuti ad errate diagnosi o errate cure.
Errare humanum est dicevano gli antichi Romani.
Ma quando è in gioco la vita delle persone occorre domandarsi in merito a che tipo di errore si tratti e se poteva essere evitato.
L’art. 32 della Costituzione Italiana recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Il Diritto alla Salute e pertanto alle cure mediche adeguate è sancito come pietra miliare del nostro sistema giuridico.
Non è però facile vedere realizzato in concreto tale fondamentale diritto.
E sempre più spesso assurgono agli altari della cronaca notizie che riguardano la malasanità.
Districarsi in queste faccende non è cosa semplice.
Lo sanno benissimo le vittime e i parenti di coloro che hanno subito un danno da malasanità.
Prima ancora di quantificare il danno subito occorre dimostrare che tale danno è la conseguenza logica-causale dell’errore medico.
L’Avvocato della vittima pertanto dovrà ricostruire tutte le fasi dell’evento e delle cure per ricostruire il “nesso causale” tra la condotta medica e il fatto dannoso.
Solo in tal caso si potrà ben sperare nell’ottenimento di un risarcimento del danno subito.
Il nesso causale tra la condotta e l’evento è la condizione prima e imprescindibile, anche se non sufficiente, per l’attribuzione del fatto al soggetto.
Il nesso causale indica il legame tra l’evento e la condotta senza il quale non vi è responsabilità in capo al soggetto che ha agito o che ha omesso di agire.
Infatti l’azione può essere sia commissiva che omissiva.
Le norme di riferimento sono da rinvenire in primis nella carta Costituzionale all’art. 27 Cost. e nel codice penale agli artt. 40 e 41, nel codice civile agli artt. 1227 e 2042 c.c..
La dottrina giuridica si è lungamente interrogata in merito all’individuazione dei criteri di causalità tra evento e condotta e ha elaborato le seguenti teorie:
- Teoria dell’equivalenza delle cause detta anche della “condicio sine qua non” o della causalità naturale, concepisce la causalità in termini logico-naturalistici: è causa di un evento l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti a produrlo. Pertanto ognuna di esse è condicio sine qua non dell’evento ed esse ai fini della produzione dell’evento si equivalgono. La condotta umana sarà causa dell’evento secondo questa teoria quando, sulla base di un giudizio causale ex post, ad evento avvenuto, sia stata anche soltanto una delle condizioni necessarie per il verificarsi dell’evento ed è accertabile come condizione necessaria quando, eliminando mentalmente tale condizione dal processo causale, l’evento verrebbe meno (sublata causa, tollitur effectus). Tale teoria però corre il rischio del regresso all’infinito da condizione a condizione, perché porta a considerare condizione dell’evento un numero indefinito di condotte umane, fino agli antecedenti più remoti.
- Teoria della causalità adeguata: è sorta per ovviare agli eccessi della causalità naturale e considera causa la condotta umana che, oltre ad essere condicio sine qua non, risulta altresì – secondo un giudizio ex ante, rapportato al momento della condotta stessa – adeguata all’evento: cioè idoneo a determinarlo secondo la prevedibilità ordinaria, cioè della comune esperienza, secondo l’id quod plerumque accidit. In questo modo sono esclusi dal novero delle condizioni causali gli effetti straordinari o atipici. Questa teoria, a differenza di quella precedente, pecca per difetto perché privilegia la scienza e l’esperienza comuni, pecca inoltre per indeterminatezza, data la genericità del criterio della scienza ed esperienza “comune”, fondato su giudizi di probabilità propri della vita “sociale”, e opera attraverso la prevedibilità ex ante dell’evento, una contaminazione tra causalità e colpevolezza.
- Teoria della causalità umana: tenta di dare una soluzione intermedia tra gli eccessi delle due teorie precedenti, e considera la condotta umana quale causa dell’evento quando ne costituisce condicio sine qua non e l’evento rientra nella sfera di dominabilità dell’uomo in base ai suoi poteri conoscitivi e volitivi, e quindi non sia dovuto all’intervento di fattori eccezionali. Pertanto, la condotta è causa soltanto degli eventi che rientrano nella sfera di controllo dell’uomo, poiché egli, anche se non li ha voluti, era in grado di impedirli. E non anche degli eventi non dominabili, cioè eccezionali, poiché dovuti al concorso di fattori sopravvenuti, ma anche simultanei o preesistenti alla condotta.
- Sussunzione sotto leggi scientifiche o “leggi di copertura”, la causalità scientifica: l’azione è causa dell’evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile dell’azione, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato con certezza o elevato grado di probabilità se il soggetto si fosse astenuto dall’azione.
L’evoluzione di queste teorie ci fa capire come si sia passati da un criterio generale che prendeva in considerazione come valide tutte le cause che si ponevano su un piano logico come antecedente all’evento dannoso, ad una metodologia sempre più scientifica capace di selezionare solo le cause capaci in concreto di determinare l’evento.
In giurisprudenza si sono succedute varie Sentenze.
Gli ermellini in primis si sono occupati di indicare le diverse modalità di accertamento del nesso causale, differenziando l’accertamento in sede civile da quello in sede penale, e hanno indicato le linee guida del corretto accertamento del nesso di causa in sede di illecito aquiliano da condotta omissiva del Sanitario (Cass. Sez. III sent. 16 Ottobre 2007 n.2169).
Facendo riferimento a tali linee guida si potrà ricostruire in concreto il legame che intercorre tra l’evento dannoso e la condotta medica che lo ha generato.
La più recente giurisprudenza si pone in linea con l’orientamento della Suprema Corte ribadendo che incombe in capo al danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità tra l’azione e l’evento.
In materia di responsabilità medica è onere del danneggiato dare la prova del nesso di causalità tra l’azione e/o l’omissione della condotta medica restando a carico dell’obbligato (ossia il medico) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (vedi Tribunale di Milano Sez. I Sent. 05/02/2020).
Ancora la Corte si è espressa in tema di causalità medica pronunciandosi circa il nesso di causalità in una recentissima sentenza (vedi Cass. Civ. Sez. III 08/01/2020 n.122) in cui ha statuito che è riferibile a colpa del medico solo un fatto prevedibile ed evitabile, pertanto i fatti imprevedibili ed evitabili secondo la migliore scienza medica rientrano nel novero della causa non imputabile.